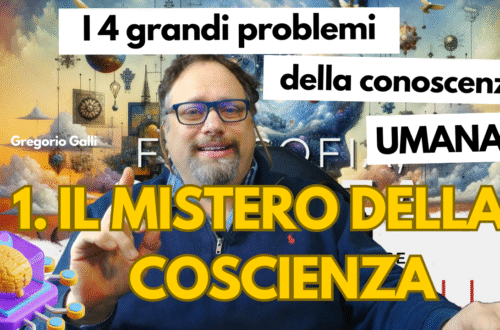Ettore Majorana e il Metodo: Una Lezione per le Scienze contemporanee e future
(brogliaccio del video: www.youtube.com/watch?v=8pb5Xrvrxxo)
Intro 1937. Ettore Majorana scrive una lettera a suo zio Dante. Beh, direte voi, e quindi? Quindi non è una lettera qualunque. Si tratta di una riflessione quasi profetica sul metodo scientifico e sull’unità del sapere umano. Di questo parliamo oggi, di un brevissimo testo che racchiude in sé la potenza di un vero e proprio trattato sul metodo delle scienze. Ma prima di entrare nel cuore del testo, facciamo un passo indietro e intanto che voi mettete like e vi iscrivete al canale ecco la… SIGLA per i 5000 iscritti!
Intermezzo
Eh, già! Prima di iniziare con l’argomento della lettera di Majorana allo zio, questo è un video atipico non solo perché ci perderemo tra le riflessioni di quello che è stato uno delle più grandi menti del XX secolo, ma anche perché voglio dedicarlo a tutti gli iscritti presenti e futuri al mio canale! Grazie a tutti voi, grazie soprattutto a quelli tra voi che commentano e mi fanno sentire che non sono solo, in questo sforzo di riflessione sulla filosofia, sulla scienza e, in fondo, sul superamento dell’assurda barriera che qualcuno ancora oggi pensa separi le scienze della natura da quelle dell’uomo. Non c’è nessuna barriera, questo è il grido di battaglia che mi anima. Bene, insomma, grazie a tutti voi che mi seguite e che, spero, in futuro troverete sempre maggiori motivi per partecipare a questa mia strana avventura! Ma torniamo al grande Ettore Majorana.
Sezione 1: Il genio di Majorana e il mistero della sua scomparsa La prima volta che mi sono imbattuto nella leggendaria figura di Majorana, penso sia stato quando ero un ragazzino, grazie al testo dell’indagine dedicata al mistero del destino del fisico siciliano da un altro grandissimo italiano, Leonardo Sciascia con il suo “La scomparsa di Majorana”. Non una delle sue più grandi opere, ma certamente un libro affascinante. Ve lo consiglio, insieme alle altre fonti che vi lascio in descrizione.
E, insomma, chi era Ettore Majorana? In breve siciliano, nato da una famiglia colta e influente, è stato riconosciutamente, nonostante la sua prematura scomparsa e la brevissima vita, uno dei più brillanti fisici teorici del Novecento. Formatosi nella cerchia dei “ragazzi di via Panisperna”, il gruppo di fisici italiani che rivoluzionò in più di un modo la fisica del tempo, prima di fuggire e disperdersi a causa del fascismo, era da loro considerato il migliore tra tutti. E questo giudizio condiviso ci è stato trasmesso non da uno a caso, ma da Enrico Fermi, capo carismatico del gruppo e a sua volta grandissimo scienziato: Non sarà mica un caso che tutte le particelle che costituiscono la materia ordinaria si chiamino collettivamente “FERMIONI”? No?
Fermi sosteneva candidamente di ritenere Majorana superiore a tutti, un intelletto “al pari di Galileo e Newton”. Da brividi, non trovate?
A maggior riprova della estrema rilevanza del personaggio, nel 1933 Majorana trascorre un periodo a Lipsia, dove lavora a stretto contatto con Werner Heisenberg, padre celebre della meccanica quantistica e del noto principio di indeterminazione.
Il rapporto tra i due fu di profonda stima reciproca: Heisenberg rimase colpito dal rigore e dall’originalità del pensiero di Majorana, e lo invitò più volte a pubblicare i suoi lavori in tedesco, per una loro maggiore diffusione. Infatti, lo dico per inciso, all’epoca ognuno pubblicava nella propria lingua: ci sarebbe voluto l’esito della seconda guerra mondiale, perché l’inglese diventasse la lingua franca della scienza.
Majorana, tuttavia, rifiutò, restando fedele alla propria ritrosia alla pubblicazione e alla visibilità. Questo incontro fu però fondamentale per l’approfondimento di alcuni concetti della teoria dei neutrini, e lasciò una traccia indelebile nella considerazione che l’ambiente scientifico europeo aveva del fisico siciliano.
I suoi contributi alla meccanica quantistica e alla fisica delle particelle sono ancora oggi oggetto di studi: basti pensare alle ‘particelle di Majorana’, ipotetiche particelle che sono anche le proprie antiparticelle e che giocano un ruolo fondamentale in alcuni modelli teorici di fisica e nelle ricerche sulla materia oscura e nelle prospettive del calcolo quantistico. Ma questo è un altro video, o un’altra serie di video.
Ma, insomma, nonostante il suo interesse per una gamma vastissima di problemi scientifici, Majorana pubblicò pochissimo. Molti dei suoi scritti rimasero e sono ancora inediti, manoscritti custoditi e studiati solo decenni dopo la sua scomparsa e che ancora oggi continuano a soprendere gli studiosi con nuove intuizioni. Altri suoi testi, compreso appunto un ipotetico trattato sul metodo scientifico sono semplicemente scomparsi. Si immagina che questo lavoro fosse una trattazione estensiva dei concetti affrontati nel brevissimo frammento di cui vi voglio parlare oggi.
Majorana era un uomo fuori dal comune in molti modi. Anche la sua scomparsa è diventata leggenda: nel marzo del 1938, Majorana si imbarcò su un traghetto da Palermo a Napoli, ma non arrivò mai a destinazione. Da allora, nessuno lo ha più visto. Morte volontaria? Ritiro in un monastero? Fuga in Sud America? Il mistero di Majorana resta aperto ed è stato occasione di lavori letterari, film e, addirittura, fantasiose speculazione da parte di veri e propri imbroglioni. Ma a questo ultimo aspetto mi sono ripromesso di non dare spazio, qui. Ne riparleremo forse in seguito.
Insomma, molte sue idee rimangono e di altre ci ha lasciato tracce. Tra queste tracce, c’è questa lettera, che oggi analizzeremo insieme.
È una riflessione, quella che qui Majorana affronta in poche parole, che mi ha risuonava dentro anche molto prima di imbattermi in una citazione parziale del testo, in un libro di Giorello e Barone.
Probabilmente Majorana aveva fatto leggere lo scritto originale a cui si riferisce Giorello a suo zio Dante, perché gli scrive “Grazie anche per i tuoi commenti sul metodo. Permettimi di aggiungere una mia impressione.” Ho sempre trovato curioso che questo dialogo intercorra tra Ettore e lo zio Dante, che era un famoso giurista, e non, tanto per dire con un altro suo zio celebre, il fisico Quirino Majorana. Ma questo non c’entra.
Bene, dopo questa lunga introduzione passiamo allora alla lettera in sé. Non ho potuto trovare l’edizione integrale delle lettere di Majorana, l’unica che mi risulti esistere, che dovrebbe essere nel secondo numero del Giornale critico della filosofia italiana del 1988, sotto il titolo “Lettere inedite di Ettore Majorana a Giovanni Gentile jr.”, detto Giovannino.
Non avendo avuto fortuna, nel reperire quel volume, ho però trovato la lettera pubblicata integralmente sull’enciclopedia Treccani, alla voce “Majorana, Ettore”. Vi lascio, come per il resto il link in descrizione.
E quindi cosa ci dice allora sul Metodo, Ettore Majorana?
Sezione 2: L’unità della scienza e la pluralità dei metodi “Io credo nell’unità della scienza, ma appunto perché ci credo sul serio, penso che finché esisteranno praticamente scienze distinte con oggetti diversi, nessuno errore sia così pernicioso come la confusione dei metodi.”
Majorana parte da qui: l’unità non è uniformità. Credere nell’unità della scienza, quindi nell’unitarietà della realtà, mi azzarderei a dire, significa riconoscere che ogni disciplina ha i suoi oggetti e i suoi strumenti. Ma fermarsi a questa interpretazion e sarebbe una lettura superficiale, perché sarebbe facile pensare che lui intendesse che questa divisione sia immutabile. Ci dice invece “finché esisteranno praticamente scienze distinte”. Il che significa che la distinzione non è fondamentale ma pratica, legata al modo in cui ogni disciplina è nata e si è evoluta, non alle radici nella realtà – perdonatemi, stavo per dire “radici ontologiche” – di una data disciplina.
Questo passaggio è un’indicazione temporale, storica. “Finché” significa che lo stato delle discipline scientifiche è provvisorio, e che nuove connessioni o integrazioni tra ambiti potranno emergere nel futuro, in modi oggi inimmaginabili. Ma finché questo stato di cose perdurerà niente è più sbagliato di pensare di poter usare i metodi della fisica in sociologia o, se è per questo, in biologia.
Questa riflessione anticipa di molto temi che oggi sono al centro della filosofia della scienza: il problema dell’interdisciplinarietà e della transdisciplinarietà, ma anche, non posso fare a meno di pensarlo, l’emergenza dei fenomeni di livello organizzativo superiore dalle regole più semplici degli elementi e delle leggi a livello di complessità inferiore.
Ma insomma, non è con l’uso di modelli presi in prestito dalle scienze “più fondamentali” e adattati a forza a scenari epistemologici completamente diversi, che si può raggiungere un livello maggiore di comprensione di un certo ambito disciplinare o, addirittura, delle fondamenta della realtà stessa. Majorana sottolinea la tensione tra rigore e adattamento metodologico, e invita a uno sguardo non banalizzante su questi aspetti della conoscenza umana.
Sezione 3: Il metodo matematico e i suoi limiti attuali “In particolare il metodo matematico non può essere di alcuna sostanziale utilità in scienze che sono attualmente estranee alla fisica.”
È ancora una volta fondamentale qui l’avverbio: “attualmente”. Majorana sottintende che un giorno ciò possa cambiare. E di fatto molto è cambiato nell’uso che della matematica facciamo nello studio di discipline molto lontane dalla fisica. Non bisogna però fraintendere questo uso strumentale, come per esempio quello che ne fa l’economia, attravero i modelli, con quello a cui stava davvero pensando Majorana. Vedete: per un fisico la matematica è un modo per penetrare le basi della realtà o, quantomeno, dipende dal fisico, uno strumento per definire regolarità e leggi. L’uso che oggi che si fa della matematica in ambiti molto distanti dalla fisica è “pratico”, non fondamentale, non ha a che fare con le radici delle materie stesse. Per Majorana la matematica è lo strumento fondante della fisica, che ha costituito con essa una straordinaria unione, una potente spiegazione delle fondamenta del mondo.
Ma le altre discipline — la biologia, la psicologia, le scienze umane — non sono ancora integrate in questa cornice teorica, per quanto possano all’occasione fare uso di modelli matematici statistici o simili.
Dalle parole di Majorana è chiaro che non si tratta di un giudizio di valore su tali discipline, ma di un’analisi dello stato attuale. Se un giorno la fisica si estenderà, cambiando i propri principi, allora anche il metodo matematico potrebbe diventare applicabile a nuovi ambiti. Ma questo non avverrà per semplice sviluppo lineare: servirà una rivoluzione concettuale. Ma di questo dirà lui e leggeremo noi tra un poco.
Intanto, dice ancora Majorana: “In altre parole, se un giorno si scoprirà la faccia matematica dei più semplici fatti della vita o della coscienza, questo certissimamente non accadrà per una naturale evoluzione della biologia o della psicologia, ma solo perché qualche ulteriore radicale rinnovamento dei principi generali della fisica permetterà di estenderne il dominio in campi che le sono ancora estranei.”
Non ci può quindi essere, dal suo punto di vista, e io non posso che essere d’accordo, un procedere dall’alto verso il basso, in cui l’evoluzione delle discipline più prossime all’umano si espandano ad includere questioni fondamentali. Dovrà essere l’estendersi dei metodi della fisica, a raggiungere le altre discipline lambendole dapprima per poi inglobarle a livello epistemologico e, adesso lo devo proprio dire, anche ontologico.
Non posso fare a meno di pensare alla cacofonia in cui mi imbatto quotidianamente nei miei correnti studi sulle scienze cognitive, in cui mi sembra regnare incontrastato un approccio generalmente qualitativo, salvo che per il lavoro di certi neuroscienziati. Ma ne parleremo poi. Intanto vediamo cosa ci ha lasciato in eredità l’alchimia medioevale.
Sezione 4: La chimica come caso emblematico Dice quindi Majorana: “L’esempio più significativo è offerto dalla chimica che dopo essere vissuta a lungo e con grande gloria come scienza indipendente è stata negli ultimi anni integralmente assorbita dalla fisica. Ciò è stato reso possibile dal sorgere della meccanica quantistica, mentre nessun utile rapporto si era potuto stabilire fra la chimica e la meccanica classica.”
Qui si introduce una prospettiva ancora più esplicitamente storica, ovviamente induttiva ma sicuramente piuttosto convincente: l’evoluzione del sapere non è lineare, è fatta di discontinuità. La fisica classica non riusciva a dire nulla sugli atomi. La meccanica quantistica, invece, ha permesso di inglobare la chimica, grazie a una completamente rinnovata comprensione di come molecole ed elettroni esistono e interagiscono. Ma questo è successo proprio perché la fisica ha cambiato se stessa rivoluzionandosi fin dalle sue fondamenta, non grazie a una rivoluzione all’interno della chimica.
È una lezione importante: non è la fisica che si è semplicemente estesa, è la fisica che per allargare il suo dominio è dovuta cambiare completamente. Le vere integrazioni tra discipline, sembra, nascono solo quando cambia la struttura dei paradigmi fondamentali.
Intermezzo tattico
Un momentino di pausa! Prima di passare all’ultimissima frase della lettera di Majorana ricordatevi magari di mettere un bel commento tattico. Magari scrivete “Forza Ettore!!!”, iscrivetevi e mettete like. Per me è una bella mano e poi così festeggiamo degnamente insieme il fatto di essere arrivati ad essere 5000!!!
Sezione 5: La fisica che verrà e l’umiltà epistemica Ma torniamo alla lettera. Infine Majorana scrive: “In attesa che la fisica compia nuovi miracoli, si dovrebbe quindi raccomandare ai cultori delle altre discipline di affidarsi ai metodi propri di ciascuna, e di non cercare modelli o suggestioni nella fisica di oggi, meno ancora in quella di ieri, perché la fisica che potrà un giorno dire la verità definitiva su fatti biologici o morali, è qualche cosa di cui non abbiamo ancora alcun presentimento.”
Mi commuovo quasi, a leggere questa frase.
Qui abbiamo una profondità nella concisione che mi sconcerta sempre, ma non mi sorprende affatto, dato chi ha scritto queste parole. Majorana invita a non cercare risposte per le “altre” scienze nella fisica di oggi, meno ancora in quella di ieri ma pare convinto che sarà la fisica di domani a creare i presupposti per dare risposte integrate ai fondamenti di altre discipline. Nel mio piccolo condivido totalmente questa convinzione. Le grandi rivoluzioni del pensiero scientifico non possono essere previste né anticipate, solo intuite.
Sono in una prima fase rotture drammatiche nel tessuto del pensiero e solo in una fase successiva, di calma, evoluzioni attraverso la “scienza normale”. Questo farebbe quasi sospettare che Thomas Kuhn – l’autore de “la struttura delle rivoluzioni scientifiche” – avesse letto la nostra lettera, ma ne dubito. Il fatto è che l’idea della rivoluzione paradigmatica come discontinuità è nata molto tempo prima. Diciamo che l’idea era nell’aria fin dal ‘600, dalla rivoluzione provocata da Copernico e Galilei.
Adesso “non abbiamo ancora alcun presentimento” di ciò che sarà la fisica di domani, non ne possiamo avere, proprio come i fisici dell’era pre quantistica non avrebbero potuto neanche lontanamente immaginare gli sviluppi successivi della loro disciplina.
La lettera potrebbe sembrare adombrare la cosiddetta umiltà epistemica. Cioè la consapevolezza che il nostro sapere, per quanto avanzato, è sempre provvisorio ed è certamente così. Ma al fondo pare riservare una certezza incrollabile sul progresso futuro della scienza umana, attraverso inattesi e imprevedibili progressi.
Insomma, ribadiamolo, l’espansione del sapere richiede sempre prima una trasformazione profonda delle basi. C’è molto di induttivo e forse pure un pizzico di storicismo, in tutto questo. Ma non si può, quando si dedica la vita a esplorare i territori infidi del mondo teorico, rinunciare alla bussola della convinzione incrollabile che al di là delle prossime montagne si estandano nuovi e più ricchi territori. Sarebbe assurdo, al limite del disfattismo, pensarla altrimenti. Ci sono degli assunti metafisici inevitabili per questa esplorazione. C’è l’idea che mi piace chiamare monista, dell’unità di tutte le cose in un’unica sostanza o legge fondamentale, c’è la convinzione che la mente umana, evolutasi nelle piane africane, sia in grado di tutto comprendere e, più banalmente, c’è la convinzione che le rivoluzioni scintifiche siano qualcosa di reale, che si ripete. Le prime due sono qualcosa che io amo chiamare “gusto metafisico”: si sceglie la base delle nostre convinzioni in base al gusto che abbiamo sviluppato in base alla nostra educazione e alla nostra storia personale. Il mio personale gusto preferito è, appunto, che tutto è fisica, ma ogni tanto ci metto sopra una cucchiata di pensiero magico. Altri penseranno che i mondi sono sospinti da angeli intorno a una terra piatta. È tutta questione di gusti. Ma vedo che divago. Ma ho fatto di peggio, scrivendo questo video!
Piccoli ripensamenti. Alcune considerazioni su una scienza un po’ speciale: le scienze cognitive
E infatti qui mi dovete essere grati! Perché mi ero lanciato, dopo le mie banalità metafisiche, in una tale disamina sulle scienze cognitive che ne veniva fuori una specie di pamphlet. Quando però mi sono reso conto dove stavo andando a parare, ho fatto taglia e incolla e dunque, sul rapporto tra metodo, fisica e scienze cognitive farò un video successivo. In gran parte tanto è già scritto!
Una sola considerazione, collegata a quanto dice Majorana sul metodo delle scienze. Ci sono molti, nelle scienze cognitive, in particolare i filosofi della mente, diciamo alcuni filosofi della mente, che pensano di poter indagare le fondamenta della realtà attraverso le loro riflessioni qualitative sull’organo biologico con cui quella realtà noi la indaghiamo. Ebbene, al di là di forme francamente reazionarie di idealismo o di dualismo, e senza considerare come potrebbero rivelarsi circolari certi ragionamenti, forte di avere alle spalle Majorana, mi spingo ad affermare che questo è un sogno allucinatorio.
Pensare che le fondamenta della realtà, l’ontologia delle cose, si possa desumere – perdonatemi, stavo per dire sussumere – attraverso il discorso intorno a qualcosa di cui non si comprendono le basi teoriche, è proprio un genere disturbante di “presunzione epistemica” che non conta quanto disturbi me o voi ma, credetemi, disturba anche gli scienziati cognitivi, data l’enorme confusione di teorie inconcludenti che regna nel loro campo. Ma appunto, rimandiamo questa polemica a un prossimo video. E torniamo a delle battute finali sullo scritto e sul metodo di Majorana.
Conclusione Il rigore non è imporre un metodo unico tra le discipline, ma scegliere per ogni campo di studio i metodi che gli sono più consoni ma anche gli obbiettivi. E direi anche gli obiettivi che sono realisticamente perseguibili da una data disciplina.
Le rivoluzioni, quelle vere, nascono sempre quando sappiamo riconoscere i limiti di ciò che oggi crediamo assoluto. Come ha fatto Majorana, come ribadito dalla teorie dell’umiltà epistemologica.
Dietro queste poche righe scritte da un grande intelletto, c’è una visione del sapere ancora viva, che si nutre di una convinzione che io condivido profondamente e che, mi scuso per la gretta semplicità con cui la formulo, si riassume, ancora una volta, in una semplice convinzione: tutto è fisica. Ma in modo tuttaltro che banale.
E se oggi dovessi scommettere su quale potrebbe essere la prossima rivoluzione che costringerà la fisica a cambiare se stessa e ad estendere la matematica oltre i limiti che oggi ci sembrano invalicabili, mi sentirei di puntare sul fatto che ciò passerà dall’inclusione nella sua struttura teorica più profonda dei meccanismi dell’emergenza.
Cioè dei modi in cui, attraverso transizioni di scala, possiamo passare dal dominio della meccanica quantistica al regno della fisica classica, attraverso la chimica, su su verso livelli sempre maggiori di complessità e organizzazione, fino alla vita, alla natura, e al più complesso sistema che mai abbiamo incontrato: la mente umana.
Forse sarà proprio in quel punto che la fisica troverà la sua prossima metamorfosi, quando con i mezzi della matematica potremo finalmente spiegare e non semplicemente cercare di modellizzare il motivo per cui, ed è solo un esempio, dal comportamento meccanico e semplicissimo di una singola formica, si possa originare la struttura fisica e biologica infinitamente ricca e complessa del formicaio.
Ma questa è ovviamente una mia opinione o, anche meglio, un mio desiderio e non c’entra più di tanto con la riflessione di Majorana, che appartiente comunque a un altro tempo ed è racchiusa in poche frasi facilmente manipolabili.
E pensando a questo mi chiedo: il mitologico trattato sul metodo di Majorana verrà mai ritrovato? Certo, data la ricca collezione di scritti falsi che gli sono oggi attribuiti, ci sarebbe da considerarlo con un a certa prudenza, ma se reale e possibile, sarebbe, ne sono convinto, un ritrovamento fondamentale.
Bene, chiudo qui, ditemi nei commenti qual è, secondo voi, la prossima rivoluzione scientifica che cambierà tutto. Intanto acnora grazie per essere parte di questa comunità. 5000 volte grazie. E avanti, insieme, ad esplorare le visioni più pericolose e intriganti della filosofia e della scienza.
Un saluto. Ciao!
Fonti:
I link Amazon sono sponsorizzati
- La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia: amzn.to/4ik1yjF
- La banda di via Panisperna: Fermi, Majorana e i fisici che hanno cambiato la storia di Giorgio Colangelo e Massimo Temporelli (non un granché, giusto per chi non conosce la storia del gruppo di fisici italiani): amzn.to/4j8TqDT
- I Ragazzi Di Via Panisperna di Gianni Amelio (film per la TV): amzn.to/42GKwr8
- La matematica della natura di Vincenzo Barone e Giulio Giorello: amzn.to/4csDQ3b
- “Lettere inedite di Ettore Majorana a Giovanni Gentile jr.”, in Giornale critico della filosofia italiana, vol. 8, fasc. 2 del 1988: introvabile
- Majorana, Ettore in Enciclopedia Treccani: www.treccani.it/enciclopedia/ettore-majorana_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Scienze)/
- La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas S. Kuhn: amzn.to/3E5k8Ow
- Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione di Alexandre Koyré: amzn.to/4cP5aJr
- Knowing Our Limits di Nathan Ballantyne: amzn.to/4jpsbVa